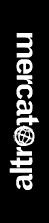J.M. Barrie: Non sono abbastanza giovane per sapere tutto. Proviamo a tornare giovani con i progetti in cerca di collaboratori del Pennazzi’s blog (Un paio di piedi per tante scarpe):
(…e chissà che il paio giusto non ci porti sulla nostra strada!)
Categorie
- 00 Rivoluzione Morbida
- 01 Decrescita Felice
- 01 Editrice "Non c'è ancora"…
- 02 Movimento della Transizione
- 02 Rivendico il diritto alla cazzata
- 03 Autoproduzione
- 03 Pennazzi's Blob
- 04 Famiglia Vaniglia
- 08 GengisGas
- 09 I migliori Amici dell'uomo
- 10 Mi scappa il post
- 11 caro zio Silvio
- 12 Il genocidio invisibile
- 13 Incontri dell'Altro Mondo
- 14 Letture dell'altro mondo
- 15 Film dell'altro mondo
- 16 Canzoni dell'altro mondo
- 17 Lab. Teatrale Balrog
- 18 Referendum e Petizioni
- 19 signoraggio bancario
- Che ridere l'Africa!
Sono talmente ecologico da riciclare anche le idee! Mi risponde Goethe: l’uomo intelligente trova ridicolo quasi tutto, quello razionale quasi niente. Chiosa Caparezza: si vive di momenti tristi e divertenti, e non di momenti tristemente divertenti.
Archivio Post
Si domanda Giorgio Gaber: Ma se improvvisamente uno diventa giusto, come si comporta in questo mondo di sbagliati? Gli risponde Ernst Fritz Schumacher: Occorre vivere più semplicemente per permettere agli altri semplicemente di vivere. Chiosa H.D. Threau: Ciascono di noi è ricco in proporzione al numero di cose di cui può fare a meno.
aprile: 2024 L M M G V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Viviamo alla rovescia: non si lavora più per vivere, ma si vive per lavorare. Si scomoda addirittura Giove per darmi risposta, Odissea-Canto 1°: L’uomo chiama destino la propria imbecillità.
-
Post recenti:
- Nazionale, tra empatia, retorica e sano populismo
- Aggiornamento Ecovillaggio
- Sono innamorato!
- Riapre l’Agricola Corbari, il nostro “spacciatore” di fiducia di Bio Frutta e Verdura!
- Avviso spostamento Pennazzi’s Blog!
- Appello alla borghesia
- Appello rivoluzionario: Fai la rivoluzione! Bastano 30 minuti alla settimana…
La decrescita è elogio dell’ozio, della lentezza e della durata; rispetto del passato; consapevolezza che non c’è progresso senza conservazione; indifferenza alle mode e all’effimero; attingere al sapere della tradizione; non identificare il nuovo col meglio, il vecchio col sorpassato, il progresso con una sequenza di cesure, la conservazione con la chiusura mentale; non chiamare consumatori gli acquirenti, perché lo scopo dell’acquistare non è il consumo ma l’uso; distinguere la qualità dalla quantità; desiderare la gioia e non il divertimento; valorizzare la dimensione spirituale e affettiva; collaborare invece di competere; sostituire il fare finalizzato a fare sempre di più con un fare bene finalizzato alla contemplazione. La decrescita è la possibilità di realizzare un nuovo Rinascimento, che liberi le persone dal ruolo di strumenti della crescita economica e ricollochi l’economia nel suo ruolo di gestione della casa comune a tutte le specie viventi in modo che tutti i suoi inquilini possano viverci al meglio. Maurizio Pallante
Diario di scuola (Daniel Pennac e l’auspicio della decrescita felice!)
settembre 12, 2008 — Arcano PennazziNon hai avuto il mondo in eredità da tuo padre, ma in prestito per i tuoi figli! Quindi è ora di scegliere “Altro” perché quello che c’è puo’ essere migliorato cambiando in meglio:
1° Altra energia
2° Altra Acqua
Aggratiss!!
Altra carta
Altra Informazione
Altra mobilità
Altra Spesa
Altra Tv
Altre Banche
Altri Comuni
Altri Marchi
Dal dire al fare
Io c'ero.. e tu?
Link Amici